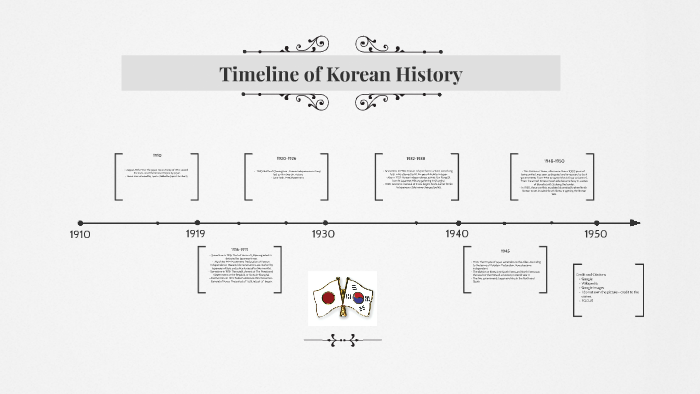Come promesso, ecco la continuazione della serie di post ispirati al documentario “The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies”. In questo nuovo capitolo vi racconterò l’atroce storia raccontata negli episodi dedicati agli omicidi della banda chijon.
E prima di cominciare devo dirvelo subito, in modo onesto, come faccio sempre qui sul KDG: questa è una storia che graffia. È dura, cupa, e più si va avanti più si ha la sensazione di guardare qualcosa che non dovrebbe esistere nel mondo reale. Non parliamo “solo” di violenza. Parliamo di un gruppo di ragazzi che si è costruito addosso un’ideologia di odio, l’ha trasformata in rituale, e poi l’ha usata come scusa per superare ogni limite umano. E parliamo anche di una donna che si è ritrovata dentro quell’inferno e ne è uscita… contro ogni logica, contro ogni previsione, contro tutto.
La cosa che mi colpisce ogni volta, quando una storia del genere riemerge, è che non si presenta mai con un cartello luminoso. Arriva sempre come qualcosa di “normale”. Una chiamata. Un incidente. Un fascicolo chiuso in fretta. Un’ipotesi facile. E invece, dietro, c’è una voragine.
È l’11 settembre 1994 quando una volante raggiunge la scena di un presunto incidente nel sud-ovest della Corea. In fondo a una scarpata breve ma ripida c’è una Hyundai Grandeur: davanti e ai lati è schiacciata, il parabrezza è una ragnatela di crepe. Basta poco per pensare che l’auto sia precipitata di muso, forse nei giorni precedenti. Uno degli agenti sale fino al bordo e trova segni di pneumatici che portano dritti oltre l’orlo, esattamente sopra dove la macchina si è fermata. L’altro rimane giù, a guardare quell’abitacolo devastato, e attraverso le crepe vede una sagoma curva sul volante. C’è qualcuno lì dentro. E bisogna capire chi è, e perché è finito di sotto.
Quando aprono la portiera, il primo colpo è l’odore: alcool, un odore così forte da sembrare già una risposta. L’uomo ha un documento addosso: si chiama Lee Jong-won, ha 36 anni, è un musicista, viene da fuori Seoul, a oltre quattro ore di distanza. Per un momento, nella testa di chi guarda, tutto si sistema in modo fin troppo semplice: alcol, guida, errore, scarpata. Caso chiuso.
Solo che la realtà non ha mai rispetto per le soluzioni facili.
Perché quando il corpo viene spostato per osservarlo meglio, la scena cambia forma. E diventa qualcos’altro. Lee Jong-won è coperto di ferite da coltello. Pugnalate nette, coerenti con colpi inferti con una lama. Non possono essere state causate dall’incidente. E in quell’istante, anche senza sapere ancora niente, la domanda diventa una sola: che diavolo è successo qui?
Quasi nello stesso momento, altrove, un’altra chiamata arriva alla polizia. È la famiglia di una donna: Ms. Lee, 27 anni, legata a Lee Jong-won come amante segreta. Da due giorni non risponde, non si fa sentire, non torna. È scomparsa. E per chi guarda l’orologio e mette insieme le ore, il nodo si stringe: il tempo stimato dell’incidente coincide con il momento in cui Ms. Lee smette di contattare la famiglia.
Ma qui si apre un dettaglio che pesa come un macigno, e che racconta il clima di quel periodo: nella Corea del Sud degli anni ’90 non esisteva l’immaginario di “unità speciali” come lo intendiamo oggi. C’erano poliziotti. E, a sentire chi ha vissuto quegli anni, c’erano anche poche risorse. Poca tecnologia. Pochi fondi. E un’abitudine quasi obbligata a pensare in modo lineare: se senti zoccoli, devi immaginare un cavallo. Non puoi permetterti di cercare zebre.
Eppure, questa volta, la zebra è lì. È nel sangue. È nelle coltellate. È nel vuoto lasciato da una ragazza che non si trova.
Perché mentre quell’auto viene osservata, mentre i dettagli iniziano a non combaciare, Ms. Lee è viva. E sta vivendo due giorni che non assomigliano a niente di reale. È chiusa in un ambiente di cemento sporco che i suoi rapitori chiamano senza vergogna “la Murder House”. Un recinto grigio che sembra costruito apposta per spezzare la mente prima ancora del corpo. È sorvegliata continuamente da cinque ragazzi, tutti nei primi vent’anni, e da una ragazza dall’aria annoiata che lei capisce essere la fidanzata di uno di loro.
E Ms. Lee si chiede se uscirà mai. Se la polizia troverà il corpo del suo compagno e capirà che non è un incidente. Ma soprattutto si chiede una cosa che fa paura anche solo a scriverla: chi mi crederebbe? Perché quello che ha visto, quello che ha subito, quello che sta ancora per subire, è talmente assurdo da sembrare inventato.
Tutto era iniziato alle 3 del mattino dell’8 settembre 1994. Una strada di campagna buia fuori Seoul. Ms. Lee e Lee Jong-won tornano da un motel, ognuno verso la propria vita — e sì, è una relazione clandestina, di quelle che esistono e bruciano in silenzio. Mentre guidano, nello specchietto compaiono due coppie di fari: un’auto piccola e un camion cargo. Stanno dietro. Troppo vicini. Troppo a lungo. Non cambiano velocità, non sorpassano, non spariscono. Rimangono incollati come un’ombra aggressiva.
Lee Jong-won prova a tranquillizzarla: esce dalla superstrada per farli passare. Ma appena mette la freccia, il camion ruggisce e accelera. Lo supera, gli si piazza davanti, frena di colpo e lo costringe a fermarsi. Lee Jong-won tenta di fare retromarcia, ma l’auto piccola si è già incastrata dietro. Sono bloccati, schiacciati tra due veicoli.
E poi arriva il silenzio, quel silenzio terribile che precede il disastro.
La portiera del camion si apre. Scendono alcuni giovani. Circondano l’auto. Uno si avvicina al finestrino, tira fuori un’arma e spara dentro. Le portiere vengono spalancate, mani che afferrano, corpi trascinati. Ms. Lee viene picchiata. Compare un coltello: Lee Jong-won viene pugnalato mentre cerca di difenderla. È ferito ma vivo. In meno di due minuti, la loro vita è stata ribaltata: occhi e bocca coperti con nastro, mani e piedi legati, caricati sul camion e portati via.
Quando Ms. Lee torna a vedere, è dentro una casa. Cemento. Luci bianche e fredde dall’alto. Una sorta di cella improvvisata. In un angolo, qualcosa che sembra un incrocio tra un barbecue e un inceneritore. L’insieme ha quell’estetica da incubo che ti fa pensare a un film dell’orrore — solo che qui non c’è nessuna scritta “fine riprese”.
E i rapitori… sono la parte più disturbante. Perché la violenza dell’operazione sembra troppo “professionale” per i volti che ha davanti. Ragazzi non più grandi di 22 anni, tagli di capelli sbagliati, acne, nervosismo addosso come un tic. Camminano avanti e indietro come se nemmeno loro sapessero come si fa a essere arrivati fin lì. Come se avessero seguito un copione imparato male.
Uno di loro parla. Dice che si chiamano Chijon family. Dice che sanno che la coppia è ricca e che devono pagare. Ms. Lee e Lee Jong-won si guardano: ricchi? Lei è una cameriera, lui un musicista. Non hanno soldi. Quando chiedono come gli sia venuto in mente, ricevono una risposta che è quasi ridicola, se non fosse tragica: la Hyundai Grandeur era un’auto tipica di dirigenti e politici all’epoca. Quindi, per loro, auto “da ricchi” uguale persone ricche.
Quell’errore li irrita. Perché se non possono pagare, la logica della banda si restringe fino a diventare una sola parola: morire.
C’è un momento, all’apparenza piccolo, ma rivelatore. Portano a Ms. Lee pane e latte. Cibo triste, grigio. Lei lo guarda e dice che non ha fame. E il ragazzo che glielo ha dato esplode: chi è povero davvero non rifiuta mai cibo, nemmeno gli avanzi. Quindi per lui quella frase diventa una prova: “Ecco, lo vedi? È ricca!”. È questo il livello. È questa la mentalità: un’idea distorta della povertà e della ricchezza, trasformata in pretesto per decidere chi merita di vivere.
Da lì, la decisione: li tirano fuori dalla cella. E impongono a Ms. Lee una cosa che non dovrebbe mai essere imposta a un essere umano: partecipare.
Li fanno bere alcool in grandi quantità. Scelgono di uccidere Lee Jong-won strangolandolo, perché è così che hanno visto fare in passato. E costringono Ms. Lee a mettere le mani sul collo del suo compagno insieme a loro. Poi prendono il corpo, prendono l’auto, salgono su una scarpata. Tracciano segni di frenata. Spingono giù la macchina. Vogliono un incidente. Vogliono un cavallo, non una zebra.
E per un attimo, sembra funzionare.
Ma rimane lei. E lì, in mezzo alle loro regole assurde, emerge una spaccatura: uno dice “uccidiamola, non ci si fida delle donne”. Un altro, Hyun Yang, 21 anni, che diventa il leader di fatto, dice di no: teniamola in vita. Ms. Lee nota che lui la guarda in modo diverso, quasi con qualcosa che assomiglia all’ammirazione. Non significa bontà. Non significa salvezza. Significa solo che, per ragioni confuse e sbagliate, lei resta viva.
Questo però non vuol dire essere trattata bene. Anzi. La brutalità continua. Solo che, finché respiri, esiste una fessura in cui può infilarsi la fuga. E Ms. Lee si aggrappa a quella fessura con la forza di chi non ha più niente da perdere.
In quei giorni, le danno anche dei libri. Le dicono che se vuole far parte della “famiglia” deve leggerli. Noir, storie criminali, ossessioni del loro capo. È come se tutto quello che sanno sul crimine venisse da romanzi e film. Come se volessero diventare “gangster” senza capire che, nel frattempo, stanno diventando solo carnefici ridicoli e spaventosi.
Ed è qui che bisogna fare un passo indietro, perché questa banda non nasce dal nulla nel 1994. La scia comincia a luglio 1993. Un gruppo di uomini che si conosce tramite gioco d’azzardo si unisce attorno a un leader: Kim Gi-hwan (o Kim Ki-huan), un ragazzo ossessionato da film noir e storie di criminalità. Il soprannome che si porta dietro è “Jijon”, “Supreme”, “supremamente nobile” — un’ironia tremenda, se pensiamo a quello che faranno.
La loro “identità” si nutre di rancore. Sono ragazzi cresciuti in povertà, con poca istruzione formale, e trasformano quel fallimento sociale in odio verso la società, soprattutto verso l’élite ricca. Si danno slogan come “Curse the rich” e si fissano un obiettivo delirante: “Extort 1 billion won”, circa 1 milione di dollari (o, in un’altra stima moderna, circa 1,76 milioni di dollari). Si allenano come in un culto: addestramenti duri, simulazioni di omicidi, rituali di gruppo. Leggono romanzi yakuza giapponesi. Si alimentano a vicenda con la convinzione che, per diventare “forti”, debbano smettere di essere umani.
E la prima vittima, ironicamente, non è nemmeno ricca.
Il 18 luglio 1993, verso le 23:00, cercano “target” a Daejeon. Trovano una ragazza, Choi, poco più che ventenne, figlia di contadini, povera. Non c’entra niente con la loro ideologia. Eppure la rapiscono, la portano in un’area isolata a circa 12 km e Kim Gi-hwan la uccide strangolandola, urlando al gruppo: “Ecco come si uccide una persona”. Testimonianze diranno che sembrava goffo, impacciato, come uno che non sa nemmeno se il gesto funzionerà. La seppelliscono in montagna.
Dopo quell’omicidio, Kim Gi-hwan vuole una cosa: che tutti siano implicati. Perché quando tutti hanno le mani sporche, nessuno può scappare. È una strategia di controllo, di ricatto morale, di “fratellanza” tossica.
E infatti, quando il più giovane, Song Bong Eun, diciottenne e “tesoriere”, va in panico e scappa portandosi via alcuni milioni di won, diventa subito un bersaglio. Ha infranto la regola: chi tradisce deve morire. Lo trovano, lo portano su un’altra montagna e lo uccidono a turni colpendolo alla testa con un piccone.
E lì accade una cosa che sembra piccola solo se non capisci quanto sia simbolica: uccidono un cane e lo mangiano. Un atto che criminologi coreani considereranno uno spartiacque: il momento in cui attraversano una linea di depravazione irreversibile. Come se si fossero costretti a guardarsi allo specchio e dirsi: “Adesso possiamo fare qualsiasi cosa”.
Passano mesi. Poi, la primavera successiva, investono su una base. Comprano una casa in un’area tranquilla nel sud-ovest, a Bulgap-myeon, un posto con appena 19 case. La casa è dipinta di azzurro e rosa, attira attenzione, ma a loro interessa il seminterrato, tutto in cemento e diviso in tre stanze. Lì costruiscono il loro “centro di detenzione” e un inceneritore. Il piano è semplice e mostruoso: rapire, rinchiudere, estorcere, uccidere, bruciare.
E quando tutto sembra “pronto”, il loro leader finisce in prigione per un altro crimine: un attacco a una ragazzina delle medie. A quel punto la banda perde la mente che li guidava. Rimangono ragazzi violenti e confusi, senza direzione, ma con una casa-cella già pronta e con l’idea fissa che l’unico modo per esistere sia continuare.
Nel frattempo entrano altri membri: Kang Dong-eun, Moon Sang Rok, Baek Byung Ok, Moon Seob, e Hyun Yang; e infine arriva anche la fidanzata, Lee Kyung-sook, che viene coinvolta a ridosso dell’arresto. Il paradosso è già scritto: avevano una regola che diceva di non fidarsi delle donne — “neanche di tua madre” — eppure la prima cosa che infrangono è proprio quella. Perché le regole, per loro, non sono mai state principi: sono state solo frasi da urlare per sentirsi qualcuno.
Quando la “Chijon family” uccide Lee Jong-won e inscena l’incidente, pensa di essersela cavata. Ma due giorni dopo, cercano nuove vittime. E qui entra una seconda coppia: So Yun-oh, 42 anni, e sua moglie Park Mija, 35 anni. Li rapiscono mentre sono al Dong Seoul Park Cemetery, durante il Chuseok, quando la gente va a sistemare le tombe di famiglia. Sono circa le 17:00 e, in quel momento, nel cimitero ci sono solo loro due. Vengono trascinati via e portati nella murder house.
Lì chiedono 100 milioni di won. So Yun-oh non è un ricco, e questo dettaglio dovrebbe bastare a fermarli. Ma non basta. Lui dice di poter arrivare forse a 80 milioni, quelli che ha per pagare i dipendenti della sua fabbrica. Chiama l’uomo che gestisce la fabbrica, inventa una scusa: un incidente in stato di ebbrezza. Gli dà un luogo d’incontro improbabile, il terminal bus di Gwangju, vicino al rifugio della banda. È lontanissimo dal contesto della fabbrica. Il dipendente si insospettisce. Ma va.
So viene portato al terminale. La moglie resta ostaggio sul camion. Il patto è chiaro: consegni il denaro, vi liberiamo. Il dipendente arriva con una borsa. Scambia il denaro con So, ma capisce che qualcosa non torna: dov’è l’auto dell’incidente? perché So non sembra ferito? E soprattutto: perché sta andando verso una macchina che aspetta nell’ombra?
So consegna i soldi. Chiede di essere liberato. E la banda fa quello che ha sempre fatto: rompe le promesse. Lo afferrano, lo ricaricano, lo trascinano di nuovo nella casa, insieme alla moglie.
Il dipendente denuncia subito ciò che ha visto: per lui è un rapimento. Chiama la polizia a Ulsan, dove si trova la fabbrica. Gli rispondono che non possono fare nulla perché è un’altra giurisdizione, deve chiamare Gwangju. Quando chiama Gwangju, accade l’assurdo: invece di controllare il luogo del rapimento, mandano tre agenti a Ulsan a investigare la fabbrica e i dirigenti, e concludono in fretta che si tratta di una fuga con un’altra donna o di un gioco finanziario. Non un rapimento. Non qualcosa di urgente.
E mentre la burocrazia costruisce scuse per non vedere, nel seminterrato di cemento la banda decide di uccidere comunque la coppia, nonostante il pagamento. Anzi: proprio perché il pagamento è avvenuto, si inventano un’idea quasi “pietosa” nella loro mente malata: ucciderli senza dolore.
E qui, di nuovo, entra Ms. Lee. La costringono a essere parte del delitto. Le mettono in mano un’arma — un fucile ad aria compressa — e la obbligano a sparare a So Yun-oh al petto a bruciapelo. Park Mija viene attaccata con coltelli e un’ascia. La sua morte non è “pietosa” per niente.
Poi arrivano i corpi. E arriva l’inceneritore. Li bruciano. Ma il fumo li spaventa. Temono che qualcuno noti qualcosa. E così fanno una cosa surreale e grottesca: organizzano un barbecue e invitano i vicini, in modo che l’inceneritore sembri parte della festa.
E dentro questo delirio, superano un altro limite: mangiano parti dei corpi. Si dice che Hyun Yang abbia mangiato una parte del polpaccio di Park Mija e che un pezzo di fegato sia stato fatto mangiare a forza a Ms. Lee. E se c’è una frase che mi resta attaccata come un chiodo arrugginito è quella attribuita a uno dei membri dopo l’arresto, Kim Hyun-yang: mangiare carne umana era “per abbandonare la nostra umanità e diventare più forti”.
Capite? È un’ideologia che si autoalimenta. Non basta uccidere. Devi “dimostrare” a te stesso di essere oltre l’umano, perché così puoi continuare senza crollare.
Ed è qui che, per paradosso, la loro stupidità li tradisce. Perché il giorno dopo, li troviamo ubriachi, di nuovo, a giocare con la dinamite come bambini scemi. Hyun Yang si ferisce gravemente alla mano. E in quel momento, proprio nel sangue e nel panico, nasce l’unica occasione reale di fuga: un ospedale.
Ms. Lee capisce che lui non può andarci da solo. Gli propone di guidare. Lui accetta. In macchina, lui è pallido e sudato, in shock. Quando arrivano, lei entra con lui. Aspettano. E poi succede un gesto incredibile: Hyun Yang le mette in mano i suoi effetti personali per “tenerli un attimo”. Tra questi ci sono un telefono cellulare e circa 500 dollari (ma lui tiene le chiavi della macchina). Lei li guarda e sente che quello è tutto ciò che serve.
Quando Hyun Yang viene chiamato dal medico e la porta si chiude, Ms. Lee resta sola con soldi e telefono. Si chiede per un secondo se sia un test. Se lui la stia osservando. Se voglia verificare la sua “lealtà”. Ma la verità è semplice: nessun essere umano dovrebbe essere costretto a dimostrare lealtà al proprio rapitore.
Lei scatta. Corre fuori. Prende un taxi. Chiede di andare a Seoul, quattro ore. Il tassista protesta, lei dice che ha i soldi. Partono. L’ansia le esplode addosso. Il tassista cerca di scherzare: “Non preoccuparti, conosco tutte le gang della zona”. Per lei è una frase terrorizzante. Nella testa le suona come “conosco anche loro”. Si fa fermare vicino a una fattoria, scappa, convince qualcuno a chiamarle un altro taxi e riparte verso Seoul.
E quando finalmente arriva in una stazione di polizia — alle 3 del mattino del 16 settembre 1994, in uno stato confuso, instabile, quasi dissociato — racconta tutto.
Il problema è che la verità, detta così, sembra follia. Quando lei parla di corpi fatti a pezzi e carne umana, la prima reazione di chi la ascolta è che sia sotto effetto di droga. Un detective, Ko Byung-cheon, che guiderà poi l’arresto, arriva persino a controllarle i polsi, come se la storia fosse il delirio di una tossicodipendente. È una reazione umana, in un certo senso: non vuoi credere che esista una cosa del genere.
Ma Ms. Lee sa cose che non dovrebbe sapere se mentisse. Sa del caso della coppia scomparsa, So Yun-oh e Park Mija, che risultano effettivamente dispersi. Sa che Lee Jong-won non è morto in un incidente. E ci sono dati concreti: la polizia riesce a rintracciare il telefono di Mr. So, e il segnale punta proprio dove lei dice, vicino alla murder house. E il telefono che lei ha con sé risulta registrato a Kang.
A quel punto, non si può più far finta di niente.
All’alba, una squadra parte verso il sud-ovest. Un team di nove agenti, con solo quattro pistole in dotazione. Controllano la scena dell’“incidente” del musicista e ogni dettaglio combacia con il racconto di Ms. Lee. Individuano la casa, preparano un appostamento. Sono circa le 5 del mattino quando iniziano a osservare. E la cosa più assurda è che la banda è ancora lì, tutta dentro. Come se davvero credessero che Ms. Lee sarebbe tornata.
Verso le 7:30, Kang esce e sale sul camion per
comprare generi alimentari. Si accorge della polizia e tenta di seminarli. Non
ci riesce: lo buttano fuori strada e lo arrestano dopo una colluttazione. Ora
sanno che dentro ci sono ancora altri membri, armi e persino esplosivi. Devono
farli uscire senza trasformare la casa in un disastro.
E allora usano la trappola che sembra quasi teatrale:
chiamano la casa e dicono che Kang ha avuto un brutto incidente e che devono
venire in ospedale a recuperare denaro e oggetti.
Si presentano Moon Sang Rok, Hyun Yang e Lee
Kyung-sook. Appena Moon Sang Rok scende, viene arrestato. Hyun Yang e la
fidanzata scappano in macchina, dopo un inseguimento di 20 km, finiscono
per schiantarsi contro una residenza privata e vengono presi.
Restano solo in due: Moon Seob e Baek Byung Ok.
A quel punto arrivano i rinforzi. Un’unità di 20 agenti entra nella casa
e arresta Moon Seob. Baek tenta di fuggire da una finestra e corre in una
foresta di bambù, ma viene raggiunto e catturato.
È finita.
E qui arriva la parte che mette i brividi in un modo
diverso: in tribunale, non mostrano rimorso. Dicono frasi che scioccano un
paese intero, del tipo “ci dispiace non aver ucciso di più”. Uno arriva persino
a dire che si pente di non aver potuto uccidere sua madre. È come se avessero
deciso di essere mostri e di non voler più tornare indietro, perché tornare
indietro significherebbe guardare in faccia quello che sono davvero.
Durante il processo emerge anche un dettaglio che fa capire
quanto fosse reale il loro progetto: avevano la lista VIP dei clienti del
Hyundai Department Store di Gangnam, il grande simbolo del consumo di
élite. Più di 1300 nomi, e circa 70 evidenziati come obiettivi.
Quando viene chiesto cosa avrebbero fatto con quella lista, rispondono che
avrebbero iniziato il loro “vero lavoro” dopo la festa — la settimana
successiva. È un momento terribile perché ti costringe a pensare a quante
persone sarebbero potute finire dentro quel seminterrato se Ms. Lee non fosse
scappata.
E poi arrivano le condanne.
Dopo l’arresto, Ko Byung-cheon guida l’operazione
investigativa che li inchioda. È lui a dare al gruppo il nome con cui resterà
nella memoria collettiva: Jijon gang, un termine che in origine
significa “supremamente nobile”. Un nome che si ispira anche al titolo coreano
del film hongkonghese del 1989 “Casino Raiders”, amato dal leader, e che loro
stessi trasformavano in simbolo, persino indossando fasce con la scritta
“Jijon” durante gli allenamenti.
La sentenza è spietata e rapida: nel giro di poche settimane
(si parla di 25 giorni per arrivare alla decisione), la maggior parte
dei membri riceve la pena di morte. Sei di loro verranno
effettivamente giustiziati nel novembre 1995. L’unica risparmiata è Lee
Kyung-sook, non coinvolta direttamente negli omicidi: riceve tre anni,
con pena sospesa per quattro.
E il dettaglio più straniante, se ci pensate, è quasi
“poetico” in senso tragico: tra chi esce vivo da questa storia, ci sono proprio
le due donne che la banda aveva deciso di non eliminare subito. Ms. Lee,
sopravvissuta perché un uomo del gruppo si è invaghito di lei e poi perché Hyun
Yang l’ha tenuta in vita. E Lee Kyung-sook, la fidanzata. È come se la
loro stessa regola marcia sul non fidarsi delle donne si fosse ribaltata contro
di loro e li avesse traditi nel modo più netto possibile.
Ma io non riesco a chiudere questa storia solo così, con la
cronaca nuda. Perché c’è anche un dopo, e quel dopo porta un nome: Ko
Byung-cheon.
Ko nasce nel 1949 a Jeonju, nella provincia di
North Jeolla, entra in polizia nel 1976, e diventa un volto
nazionale proprio grazie a questo caso, nel 1994. Dopo quell’inferno,
continua la sua carriera fino al pensionamento nel 2009. Ma non lascia
davvero quella storia: la studia, la analizza, la porta addosso come una
cicatrice che non si chiude. Nel 2015 consegue persino un dottorato
alla Kwangwoon University, con una tesi dedicata alla banda Jijon. Nel 2021
pubblica una web novel di non-fiction che contiene il suo nome nel titolo.
E c’è una cosa che mi ha colpita più di tutte: durante il
processo, alcuni membri arrivano a scrivergli lettere per ringraziarlo di
averli trattati con dignità. Ko, in un’intervista successiva, dice una frase
che è difficile da digerire ma importante: i loro crimini non sono scusabili,
ma lui non li vede come psicopatici “nati”. Li vede come persone cresciute in
una miseria assoluta, fino a odiare il mondo.
Racconta un episodio che, in mezzo a tutto il sangue, sembra
quasi insignificante… e invece spacca il cuore: durante l’indagine, una volta
diedero loro del riso fritto “stile cinese”. E loro si illuminarono. Dissero
che era la prima volta che assaggiavano qualcosa del genere. Pulirono i piatti
e ripetevano che non sapevano nemmeno che un cibo così potesse esistere.
Non è una giustificazione. Non lo sarà mai. Ma è un
dettaglio che ti costringe a guardare la ferita sociale dietro il mostro.
Perché, alla fine, la banda chijon nasce da un rancore che si è fatto culto.
Dal desiderio di “punire i ricchi” che si è trasformato nell’atto più assurdo
possibile: non hanno ucciso un solo vero ricco. Hanno distrutto persone comuni.
Hanno trasformato la povertà in alibi e l’alibi in rituale.
E se questa storia ci resta addosso è perché ci ricorda una
cosa che fa paura: quando la società abbandona qualcuno abbastanza a lungo,
quel qualcuno può crescere con l’idea che il mondo meriti di bruciare. E quando
quell’idea si incontra con la violenza, con l’ignoranza, con il bisogno
disperato di sentirsi “qualcuno”… il risultato non è un’ideologia. È una
strage.
Eppure, in mezzo a tutto questo, c’è una sopravvissuta. Ms.
Lee. Una donna che ha corso quando avrebbe potuto arrendersi. Che ha capito la
finestra di fuga quando tutto le urlava di restare immobile. Che è entrata in
una stazione di polizia alle tre di notte, tremante e distrutta, e ha detto la
verità anche sapendo che l’avrebbero chiamata pazza.
Ed è lì che io, da spettatrice e da persona, mi fermo sempre
un secondo. Perché non so se sarei stata capace. Non so se avrei trovato la
stessa lucidità dentro il terrore. Ma so che, se oggi questa storia viene
raccontata come “il caso della banda chijon”, è perché una donna ha deciso di
vivere. E nel farlo, ha impedito che quella lista VIP diventasse un cimitero.









.png)