Le prime due puntate del
documentario Netflix The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies sono
state struggenti, difficili da guardare e impossibili da dimenticare. Per chi
segue il blog: ho già scritto delle “Case dei fratelli”, ma dopo questo
documentario ho capito che non bastava. Voglio andare più a fondo e offrire, a
chi non ha tempo o possibilità di vederlo, un racconto che deve conoscere.
Da bambina ho sempre pensato che conoscere le atrocità del mondo serva a
formarci una morale, a capire dove fermarci e, soprattutto, chi non vogliamo
diventare. Se il tempo me lo permetterà, farò una serie su tutte le tragedie
raccontate nel documentario. Intanto, cominciamo.
Ciò che avvenne al Brothers Welfare Center è considerato uno dei più gravi crimini contro i diritti umani nella Corea del Sud contemporanea. Fondato il 20 luglio 1960 come orfanotrofio (Gamman-dong Brothers Orphanage) e trasformato nel 1962 in rifugio per senzatetto sotto la guida di Park In-geun, il centro si trasferì nel 1975 a Jure-dong, a Busan, diventando di fatto un campo di internamento: recinzioni di filo spinato, cani da guardia, gestione militarizzata, sorveglianza costante. Il contesto politico è fondamentale: durante i regimi autoritari di Park Chung-hee e Chun Doo-hwan, il Ministero dell’Interno emanò l’Ordinanza n. 410 (1975), che autorizzava retate indiscriminate contro “vagabondi” e “indesiderabili” — anche minori — senza alcuna garanzia procedurale. La struttura prosperò grazie a corruzione e collusione tra funzionari locali, polizia e personale medico.
Nel corso degli anni, oltre 38.000
persone furono detenute al Brothers Welfare Center. Nel solo 1986 gli
internati censiti erano 3.975. Circa il 70% erano civili
comuni, inclusi bambini, sequestrati per strada – spesso in luoghi pubblici
come la stazione di Busan – o direttamente nelle loro abitazioni.
Subivano lavori forzati, turni fino a dieci ore al giorno anche per
i minori, pestaggi, malnutrizione, assenza di cure mediche e violenze
sessuali su donne, uomini e bambini. Le morti accertate furono 657,
secondo la Commissione per la Verità e la Riconciliazione (2022), ma il numero
reale potrebbe essere molto più alto. I corpi venivano sepolti
segretamente o venduti alle scuole di medicina per
dissezioni, a un prezzo di 3–5 milioni di won ciascuno. All’interno del centro
operava perfino una scuola che diffondeva un vero e proprio culto della
personalità verso il direttore Park In-geun, mentre nella
sezione psichiatrica si abusava di tranquillanti, creando dipendenze. In vista
dei Giochi Asiatici del 1986 e delle Olimpiadi del
1988, le retate si intensificarono per “ripulire” le città dai cosiddetti
“indesiderabili”.
Ma
l’orrore non fu opera di un solo uomo. Funzionari comunali, polizia e
medici parteciparono attivamente: eseguivano rapimenti,
falsificavano referti autoptici, redigevano ispezioni mai
svolte. Persino un assistente amministrativo del distretto Buk-gu “supervisionava”
il centro senza alcuna competenza. Le prime indagini vennero
sistematicamente ostacolate dalle autorità locali, tra cui il
sindaco di Busan Kim Joo-ho e il vice procuratore Song
Jong.
Ciò che accadeva all’interno della Brothers
Welfare Center venne alla luce nel 1986, quando Kim
Yong-won, procuratore capo della sede di Ulsan dell’Ufficio del Procuratore
Distrettuale di Busan, scoprì per caso le prime prove di abusi durante una
battuta di caccia. Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione e
sequestro, Kim documentò in modo meticoloso la corruzione e
le violazioni dei diritti umani commesse all’interno della
struttura. Il 17 gennaio 1987, cinque persone furono arrestate
presso la Stazione di Polizia Sud di Ulsan:
- Park In-geun, direttore del centro;
- Kim Don-yeong, responsabile degli affari generali;
- Joo Yeong-un, capo ufficio;
- Seong Tae-eun, caposquadra dell’unità agricola;
- Lim Chae-heum, vicecaposquadra della stessa unità.
Le accuse includevano appropriazione indebita, sequestro aggravato, violazione della legge sulla gestione della valuta estera, violazione della legge sui pascoli e violazione del codice edilizio. Nonostante la gravità dei crimini, non furono perseguiti per omicidio, percosse, occultamento o traffico di cadaveri. Durante la detenzione, Park In-geun godette di trattamenti di favore: gli furono concessi 32 permessi di uscita senza manette per motivi personali, grazie alla complicità del sergente Song, successivamente licenziato dopo le denunce della stampa.
La procura aveva inizialmente
richiesto 15 anni di carcere e una multa di 681,78 milioni di won per Park
In-geun, oltre a pene da 3 a 7 anni per i suoi complici. Tuttavia, nel
corso dei processi, le condanne furono progressivamente ridotte. La
mancata incriminazione per omicidio e altri crimini gravi,
unita alla progressiva riduzione delle pene, mostrò chiaramente la volontà
politica di minimizzare lo scandalo. L’allora presidente Chun
Doo-hwan arrivò persino a lodare Park con una frase destinata a
diventare simbolo dell’ipocrisia di Stato:
“Grazie
a persone come il direttore Park, non ci sono mendicanti per strada.”
Dopo
l’ondata di indignazione pubblica, il Ministero dell’Interno abolì
l’Ordinanza n. 410 il 16 febbraio 1987, trasferendo la
competenza in materia di senzatetto al Ministero della Salute e degli
Affari Sociali. Poche settimane dopo, con l’Ordinanza n. 523 del 6
aprile 1987, furono introdotte nuove regole per migliorare le procedure di
ammissione, la gestione delle strutture e l’orientamento
lavorativo. Il Comune di Busan sostituì il consiglio
direttivo del centro – incluso Park In-geun – con funzionari pubblici e
trasferì gli internati in altre strutture. Nel 1988, la fondazione
cambiò nome in Jaeyukwon, segnando apparentemente una nuova
fase. Ma la storia non finì lì.
Nel 1991, Park In-geun tornò a controllare tutto, fondando la Siloam House, un centro per disabili gravi. Da quel momento ampliò costantemente i suoi affari: nel 2001 vendette il terreno di Jurye-dong, trasferendo la Siloam House nel distretto di Gijang-gun; nel 2002 acquistò un centro sportivo a Jangrim-dong e, nel 2004, un complesso di sorgenti termali a Gwaebeop-dong. I media iniziarono a chiamare la sua famiglia “il conglomerato dell’assistenza sociale”, perché aveva accumulato immense ricchezze grazie ai sussidi statali: secondo il Sisa Journal (maggio 2014), il 99% dei fondi proveniva da denaro pubblico. Il terzo figlio, Park Cheon-gwang, gestiva la Siloam House, mentre altri membri amministravano attività collaterali, inclusa una istituzione religiosa non autorizzata all’interno del complesso. L’episodio portò solo a una blanda sanzione disciplinare da parte del Comune di Busan.
La rete di Park si estese anche nel
settore finanziario: depositò 2 miliardi di won derivanti
dalla vendita del terreno di Jurye-dong nella Busan Savings Bank,
intrecciando rapporti con il vicepresidente Kim Yang, e
contrasse prestiti illegali per 11,8 miliardi di won tra il
2005 e il 2009, scoperti durante una verifica statale. Nel 1995 acquistò
perfino Jobstown, un campo da golf in Australia gestito dalla
moglie, dalla figlia e dal genero — probabilmente un’operazione di riciclaggio,
secondo SBS – I Want to Know That (21 marzo 2015) e Hankyoreh.
Nel 2013, un’inchiesta del Human Rights Oreum rivelò
che le condizioni della Siloam House erano quasi
identiche a quelle del vecchio Brothers Welfare Center: i
residenti indossavano uniformi identiche e avevano capelli rasati allo stesso
modo; le persone con disabilità gravi mangiavano isolate, spesso legate
ai letti; i pasti erano poveri e causavano malnutrizione; gli
uffici erano sorvegliati da telecamere a circuito chiuso; al
terzo piano operava una chiesa non autorizzata, in violazione delle
norme pubbliche. Alcuni residenti, intervistati da News Tapa,
dissero semplicemente:
“Voglio
uscire e vivere fuori.”
Nel 2011, Park In-geun trasferì la guida della fondazione al figlio Park Cheon-gwang, che nel maggio 2014 fu condannato a tre anni di prigione per appropriazione indebita di sussidi pubblici. Poco dopo, lo stesso Park In-geun fu colpito da emorragia cerebrale e morì il 27 giugno 2016 in una casa di cura. Nonostante la morte di Park, la sua famiglia continuò a prosperare: la figlia minore e il genero aprirono un ospedale psichiatrico, mentre il secondo figlio, ex responsabile del Brothers Welfare Center, gestiva un bar e negava pubblicamente ogni abuso (JTBC – Spotlight di Lee Kyu-yeon, 7 febbraio 2019).
Il
direttore Park In-geun, fino alla fine della sua vita, negò
costantemente ogni responsabilità. In un’intervista del 2004 rilasciata
al Christian Newspaper e al Church Gospel Newspaper,
dichiarò di aver gestito la struttura “con coscienza e buone intenzioni”
e di essere stato vittima di “invidia e calunnie”. Sostenne di aver
semplicemente eseguito gli ordini dello Stato, in particolare
quelli previsti dall’Ordinanza n. 410 del Ministero dell’Interno, e
arrivò perfino a citare in giudizio il procuratore Kim Yong-won per
diffamazione, accusandolo di aver esagerato le condizioni di lavoro forzato. A
suo dire, avrebbe persino finanziato personalmente l’assistenza
agli internati. Ma le prove raccontavano un’altra verità: Park aveva sottratto
fondi pubblici e accumulato una fortuna composta da 33 terreni, condomìni,
iscrizioni a circoli di golf e riserve di valuta estera. Non
mostrò mai alcun rimorso. Anzi, esibiva con orgoglio le fotografie
della struttura del 1983, mostrando gli internati sfruttati come trofei dei
suoi “successi” alla Siloam House. Le sue dichiarazioni furono
unanimemente condannate come manipolatorie e negazioniste, perché
ignoravano la devastazione psicologica, la povertà e i disturbi mentali
permanenti di centinaia di sopravvissuti.
Molti
superstiti ebbero gravi difficoltà di reinserimento nella società. Alcuni
finirono nel crimine o soffrirono disturbi psichici e traumi permanenti. Le
famiglie, spesso divise per decenni, si ritrovarono solo molti anni dopo. Nel 2012,
il sopravvissuto Han Jong-seon, internato con la forza a 9
anni nel 1984, organizzò una protesta solitaria davanti
all’Assemblea Nazionale per chiedere giustizia. Nel suo
libro Il bambino che è sopravvissuto (scritto con Jeon
Gyu-chan e Park Rae-gun), Han racconta la sua esperienza e quella della sua
famiglia, anch’essa sequestrata e detenuta. Disse:
“È facile passare da essere umano
ad animale… ma tornare completamente da animale a essere umano è molto
difficile.”
La sua frase divenne simbolo del
trauma subito dalle vittime del Brothers Welfare Center.
Choi
Seung-woo, detenuto per quasi cinque anni a
partire dal 1982, condusse una sciopero della fame di 24 giorni nel
2019 e successivamente un sit-in ad alta quota presso
l’edificio dei membri dell’Assemblea Nazionale nel maggio 2020. Le
sue azioni, sostenute dal deputato Kim Moo-sung, contribuirono
all’approvazione, il 20 maggio 2020, dell’emendamento alla Legge
quadro per la soluzione delle questioni storiche e per la verità e la
riconciliazione, che rese possibile riaprire ufficialmente le
indagini sull’incidente.
Il 20 novembre 2018, il procuratore generale Moon
Moo-il presentò un ricorso straordinario alla Corte Suprema per
riconoscere gli errori giuridici nelle assoluzioni di Park
In-geun per il reato di sequestro aggravato. Sebbene il
principio del ne bis in idem – il divieto di essere giudicati
due volte per lo stesso fatto – impedisse di condannarlo nuovamente, il ricorso
aveva un valore simbolico: mirava a riconoscere pubblicamente i
crimini e la responsabilità dello Stato per la violazione
della “dignità umana” delle vittime.
L’11 marzo 2021, la Corte Suprema respinse il ricorso,
confermando il verdetto di non colpevolezza con la motivazione che Park aveva
agito “in conformità alle istruzioni del Ministero dell’Interno”.
Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte riconobbe la corresponsabilità dello Stato, aprendo la strada a azioni civili di risarcimento nei confronti del governo o dei familiari di Park, qualora fosse approvata una legge speciale di sostegno alle vittime del Brothers Welfare Center.
Un passo decisivo arrivò nel 2024, quando il Tribunale
Distrettuale Centrale di Seoul ordinò allo Stato di pagare
14,58 miliardi di won a 26 ex detenuti, circa il 70%
dei 20,3 miliardi richiesti, calcolando 80 milioni di won per ogni
anno di detenzione. Fu la prima sentenza a riconoscere
la responsabilità statale diretta per le atrocità commesse nel
centro. Il Ministero della Giustizia fece appello, e al 16
luglio 2025 il caso risultava ancora in revisione presso l’Alta Corte
di Seoul. Nello stesso anno, una seconda sentenza condannò
nuovamente lo Stato: il tribunale ordinò di pagare 4,5 miliardi di won (circa 3,37
milioni di dollari) a 16 ex detenuti, con lo stesso criterio
di 80 milioni di won per anno di detenzione, più un indennizzo
aggiuntivo per i danni psicologici. Questa decisione fu confermata sia
dall’Alta Corte di Seoul sia dalla Corte Suprema nel marzo
2025, diventando definitiva.
Sempre
nel 2025, anche il tribunale di Busan stabilì che lo Stato
e le autorità locali dovevano risarcire le vittime,
riconoscendo che proprio politiche come l’Ordinanza n. 410 del
Ministero dell’Interno avevano reso possibili gli abusi.
Fino ad allora, nessuna corte aveva
mai riconosciuto la responsabilità diretta del governo in casi
di abusi contro emarginati o persone con disabilità. Le sentenze di Seoul e Busan,
insieme alla relazione del 2022 della Commissione per
la Verità e la Riconciliazione, hanno ufficialmente stabilito che:
- Il Brothers Welfare Center non
fu un rifugio per senzatetto, ma un campo di internamento forzato in
cui furono detenute circa 38.000 persone, molte delle quali
erano cittadini comuni, inclusi minori.
- Autorità locali, polizia e governo centrale cooperarono attivamente nella cattura e detenzione illegale di
questi cittadini.
- Almeno 657 persone morirono, ma
il numero reale potrebbe essere molto più alto, a causa di corpi
dispersi e sepolture anonime.
- Le violazioni sistematiche dei
diritti umani – pestaggi, violenze sessuali, lavori forzati,
torture psicologiche e persino vendita di cadaveri –
furono tollerate e coperte dallo Stato.
- La motivazione ideologica di tali politiche
fu la cosiddetta “purificazione sociale”, volta a eliminare
dalla vista pubblica poveri, disabili, mendicanti e persone considerate
“indesiderabili” in vista di eventi internazionali come le Olimpiadi.
Oggi,
il Brothers Welfare Center è considerato uno dei più gravi crimini
contro l’umanità nella Corea del Sud contemporanea.
Non solo per l’entità degli abusi, ma per la complicità istituzionale e
la lentezza della giustizia, che per decenni negarono verità e
riparazione alle vittime.
Molti sopravvissuti, come Han Jong-seon e Choi
Seung-woo, hanno dedicato la vita alla ricerca di giustizia,
diventando simboli nazionali di resistenza e memoria.
Il loro coraggio ha spinto l’opinione pubblica e le istituzioni a rivedere il
passato, riconoscendo la violenza di Stato esercitata in nome del
“benessere sociale”.
L’eredità del Brothers Welfare Center continua a influenzare la Corea del Sud
anche nel XXI secolo: le organizzazioni civili e i gruppi
per i diritti umani chiedono da anni l’approvazione di una Legge
speciale di sostegno alle vittime, che preveda:
- il riconoscimento ufficiale dello status di
vittima;
- indennizzi completi;
- la creazione di un memoriale
nazionale a Busan;
- la declassificazione dei documenti
governativi ancora secretati.
Alcuni
progetti commemorativi sono già in corso, tra cui una mostra permanente
al Museo dei Diritti Umani di Seoul, che espone documenti, fotografie e
testimonianze dirette dei sopravvissuti.
Nonostante
i riconoscimenti giudiziari e le indagini ufficiali, la giustizia resta
parziale. Molti sopravvissuti vivono ancora in povertà,
con disabilità permanenti o disturbi psichici causati
dagli anni di detenzione e tortura. Le famiglie delle vittime chiedono non
solo risarcimenti, ma anche scuse ufficiali del governo e
un vero riconoscimento pubblico del ruolo dello Stato.
La Corte
Suprema, pur respingendo nel 2021 il ricorso straordinario, ha fissato un
principio destinato a restare nella storia:
“Lo
Stato ha la responsabilità di proteggere la dignità umana, e ha fallito nel
farlo.”
Questa
frase è diventata la base morale e giuridica per ulteriori
azioni collettive e per la proposta di una legge speciale di
riparazione, ancora in discussione nel 2025.
Oggi, la vicenda è oggetto di ricerche universitarie, documentari e opere teatrali, che mantengono viva la memoria e sensibilizzano le nuove generazioni. Molti studiosi lo paragonano ai campi di lavoro forzato sovietici (Gulag) o ai campi di prigionia nordcoreani, per il livello di controllo, brutalità e disumanizzazione raggiunti. Altri vi leggono una forma estrema di biopolitica, in cui lo Stato decide chi merita di essere “riabilitato” e chi invece può essere escluso o annientato in nome dell’ordine sociale.
Il
Brothers Welfare Center non fu semplicemente una struttura abusiva, ma un
intero sistema di controllo sociale legalizzato, nato dall’illusione di
proteggere la società “purificandola” dai suoi margini.
Dietro la retorica della “riabilitazione dei senzatetto” si nascondevano interessi economici, ossessioni per il decoro urbano e una cultura istituzionale del silenzio. Le testimonianze dei sopravvissuti ricordano che la dignità umana non può essere concessa o revocata dallo Stato. Oggi, il Brothers Welfare Center è ricordato come un simbolo di memoria civile, che obbliga la Corea del Sud – e il mondo intero – a confrontarsi con il dovere di garantire che nessuna politica pubblica giustifichi mai più la sofferenza di innocenti. Le voci di Han Jong-seon e Choi Seung-woo restano il promemoria che la giustizia non è completa finché la verità non viene raccontata fino in fondo, e che ogni politica pubblica deve essere fondata sulla dignità, non sull’esclusione.


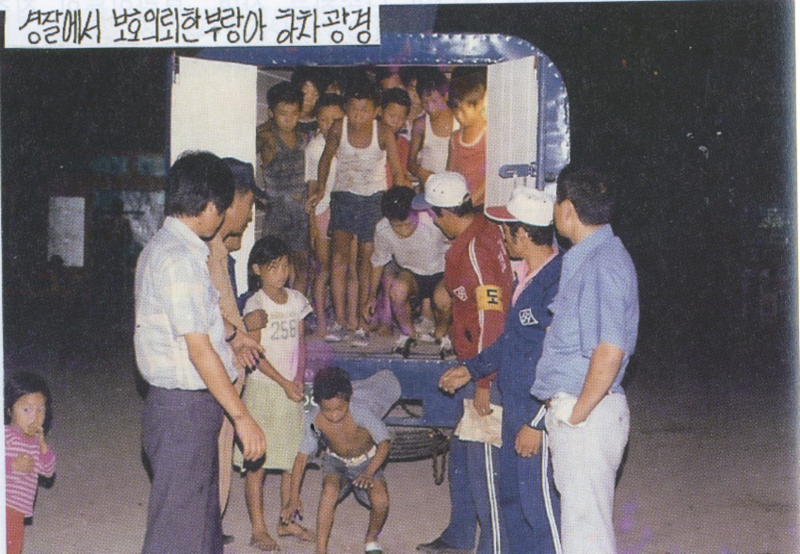



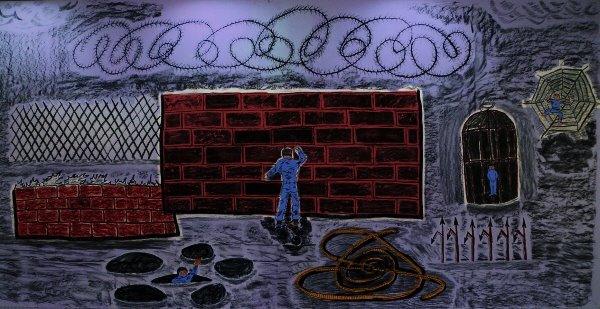




0 | +:
Posta un commento